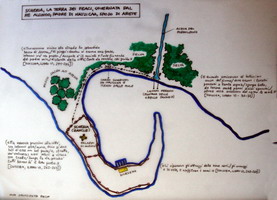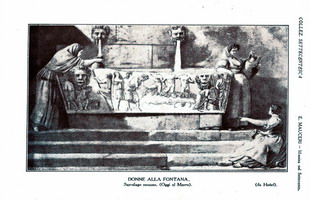Il primo ad occuparsi di Colapesce fu un poeta provenzale vissuto nella seconda metà del secolo XII, Raimon Jordan, per il quale “Nichola de Bar” è un uomo che vive da pesce (particolari della leggenda di Colapesce rimandano ad alcuni fatti miracolosi operati da S. Nicola di Bari che, durante le tempeste, lascia il porto e, scrive Giuseppe Pitrè, “cammina sulle onde con iscarpe d’erbe di mare, e col braccio invisibile conduce a luogo di sicurezza i piloti che l’hanno invocato”). Non è un caso, quindi, che Colapesce faccia la sua prima apparizione nella tradizione scritta come “Nichola” e che col nome di Nicola (o Cola) sia indicato poi nella tradizione scritta e orale. I pescatori messinesi, ad esempio, venerano S. Nicola nella chiesa di Ganzirri a lui dedicata.
Tra il XII e il XIII secolo, per il monaco inglese Walter Mapes, “Nicolaus” è un uomo che rimane a lungo immerso nel mare senza bisogno di respirare, intento ad esplorare il fondo marino alla ricerca di oggetti da riportare alla luce.
Nel 1210, per l’inglese Gervasius da Tilbury “Nicolaus” soprannominato “Papa” era un abile marinaio, pugliese di nascita, che il re Ruggero II costringe a scendere nel mare del Faro per esplorarne gli abissi (particolare interessante e unico, ai naviganti di passaggio “Nicolaus” chiede dell’olio per poter osservare meglio il fondo marino. In passato, i pescatori messinesi versavano in mare dell’olio, detto “chjarìa”, per rendere visibile il fondo marino durante la pesca dei polipi).
Nel resoconto tramandatoci da fra Salimbene de Adam da Parma, Cola (Nicola) è un pescatore messinese vissuto nel sec. XIII. Il re della Sicilia Federico II, che nel 1233 si trovava con la sua nave alla fonda nello Stretto di Messina, volendo mettere alla prova la sua valentia, lo costringe a scendere più volte nel fondo del Faro per portare alla luce una coppa d’oro lanciata in un luogo dove i gorghi risucchiano le navi. Nicola scende e pesca la coppa. Il re, sbalordito, rilancia la coppa in un tratto di mare più profondo e ordina al nuotatore di andar giù per la seconda volta. Cola riemerge nuovamente con la coppa che viene ancora lanciata da Federico, in una zona ancora più profonda. Colapesce si immerge per la terza volta ma non torna più alla superficie. Più tardi, qualcuno narrò che durante la ricerca della coppa si era accorto che una delle tre colonne che reggono la Sicilia stava cedendo. Ancora oggi egli è là, sotto Capo Peloro, a fare da colonna per salvare l’isola dallo sprofondamento in mare.
Francesco Pipino, un frate viaggiatore bolognese, nel suo “Chronicon” del 1239 parla di un giovane che fa vita da pesce da quando un giorno la madre, vedendolo sempre in mare, lo maledisse con stizza.
L’umanista Gioviano Pontano (1513) si occupa di Colapesce in un suo trattato dal titolo “De Immanitate” e in una sorta di poema astronomico-astrologico, “Urania”, dove all’avventura di “Colas” sono dedicati un centinaio di esametri.
Nel secolo XVI la leggenda di Colapesce fa la sua apparizione anche in Spagna. Pedro Mexia (1542), riferisce di aver sentito raccontare, durante la sua infanzia, di un Pesce-Cola simile al nuotatore di cui in seguito avrebbe letto la vicenda nell’opera degli scrittori italiani.
In un libretto di storia popolare pubblicato a Barcellona nel 1608, sono narrate le avventure di “Pece Nicolao” localizzate nel piccolo borgo di Rota.
Un riferimento su Colapesce si trova anche nel “Don Chisciotte” di Miguel Saavedra de Cervantes che partecipò alla battaglia di Lepanto e soggiornò nell’Ospedale Maggiore di Messina per 6 mesi. Il “cavaliere della triste figura”, deve anche saper nuotare, scrive Cervantes, “como dicen che nadaba el peje Nicolas o Nicolao”.
Nel 1678 il fisico tedesco, Athanasius Kircher, definisce Nicola “Pescecola” e per la sua abilità nel nuoto, da bambino rimane fino a cinque giorni in mare nuotando tra la Sicilia, la Calabria e le Isole Eolie.
Ancora la leggenda di Colapesce è citata dall’inglese Patrik Brydone (1870), dal francese Richard de Saint-Non (1875), da Lazzaro Spallanzani, dai poeti Domenico “Miciu” Tempio (1848) e Giovanni Meli (sec. XIX).
Una curiosità: il 7 agosto del 1797 Guglielmo Federico Schiller chiese in una lettera a Goethe chi fosse Nicola Pesce (il grande drammaturgo credeva che fosse un poeta). Tre mesi più tardi usciva “Der Taucher”, una ballata in cui la vicenda di Colapesce diviene un “dramma pieno di slancio e di passione”, scrive Giuseppe Pitrè.